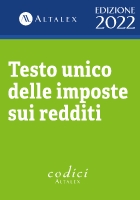La Costituzione della Repubblica Italiana
La Costituzione della Repubblica Italiana, proclamata da Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore dal 1° gennaio 1948, rappresenta la legge fondamentale dello Stato Italiano.
>> Scarica l'eBook gratuito Costituzione della Repubblica Italiana in formato PDF
 Lezioni di diritto costituzionale vivente,
di Camerlengo Quirino, Furlan Federico, Ed. CEDAM. Gli Autori del
volume hanno ricostruito gli istituti e le norme della Costituzione
vivente attraverso la chiave di lettura offerta da storia, prassi e
giurisprudenza costituzionale e facendo costante riferimento
all’attualità politico-istituzionale. Lezioni di diritto costituzionale vivente,
di Camerlengo Quirino, Furlan Federico, Ed. CEDAM. Gli Autori del
volume hanno ricostruito gli istituti e le norme della Costituzione
vivente attraverso la chiave di lettura offerta da storia, prassi e
giurisprudenza costituzionale e facendo costante riferimento
all’attualità politico-istituzionale.Scarica gratuitamente l'indice |
1. La Costituzione Italiana
La Costituzione è il documento normativo che occupa il vertice nella gerarchia delle fonti dell’ordinamento giuridico della Repubblica, c.d. Costituzione formale.
La Costituzione in senso formale va distinta dalla Costituzione materiale, espressione che indica il complesso di principi e norme effettivamente regolanti la società statale in un dato momento storico.
Si può, dunque, affermare che la legge fondamentale dello Stato Italiano è l’atto che ne delinea le caratteristiche essenziali, descrive i valori e i principi che ne sono alla base, stabilisce l’organizzazione politica su cui si regge.
Tale definizione trova riscontro diretto nella struttura dell’atto normativo de quo: la Carta costituzionale si compone di 139 articoli (alcuni abrogati dalla L. cost. 3/2001), cui si aggiungono 18 Disposizioni transitorie e finali.
I primi dodici articoli del testo costituzionale sono dedicati ai principi fondamentali della Repubblica, mentre i successivi sono divisi in due parti:
- la Parte prima riguarda i diritti e i doveri del cittadino, nell’ambito dei rapporti civili (artt. 13-28 Cost.), dei rapporti etico-sociali (artt. 29-34 Cost.), dei rapporti economici (artt. 35-47 Cost.) e dei rapporti politici (artt. 48-54 Cost.);
- la Parte Seconda (artt. 55-139 Cost.) è dedicata all’ordinamento della Repubblica, nell’ambito della quale è possibile distinguere fra organi costituzionali e organi di rilievo costituzionale(distinzione riportata nel paragrafo 14).
Infine, la Costituzione della Repubblica Italiana, presenta le seguenti caratteristiche:
- scritta: si tratta di un documento redatto in forma solenne da un organismo appositamente convocato.
- votata: adottata da un organismo democraticamente eletto, ovvero dall’Assemblea Costituente;
- rigida: non modificabile da leggi ordinarie, ma solo attraverso un procedimento legislativo aggravato, che richiede un consenso più ampio rispetto a quello della sola maggioranza;
- lunga: in quanto disciplina dettagliatamente il funzionamento degli organi costituzionali ed elenca i diritti e i doveri dei cittadini;
- garantista: poiché, attraverso le riserve di legge, garantisce una tutela più ampia ed esplicita dei diritti dei cittadini;
- programmatica: non si limita a sancire regole per l’organizzazione e l’azione dei pubblici poteri e per la disciplina dei rapporti fra questi e i cittadini, ma stabilisce anche obiettivi e programmi cui deve tendere l’attività della Repubblica;
- progressiva: prevede il graduale raggiungimento dei principi della sovranità popolare, libertà, uguaglianza, solidarietà, ecc. e si impegna, attraverso apposite leggi e atti normativi, al raggiungimento di tali fini.
2. Il Principio Democratico
Il principio democratico, enunciato all’art. 1 della Carta costituzionale, esprime l'essenza stessa della Repubblica, sancendo il riconoscimento e la trasposizione del referendum istituzionale del 2 giugno 1946, tramite il quale gli italiani, memori del recente regime monarchico, hanno optato per la forma repubblicana.
La Repubblica fonda le proprie basi sul consenso dei governati, i quali, in condizioni di perfetta parità, possono concorrere alla vita politica del Paese.
Di pari e primaria importanza è il lavoro, come mezzo per garantire l'uguaglianza dei cittadini e permetterne lo sviluppo personale.
I cittadini sono gli esclusivi detentori del potere politico, anche se, per ovvi motivi, la sovranità viene di fatto esercitata secondo modalità e con l'ausilio di soggetti diversi da essi, c.d. democrazia indiretta.
La sovranità appartiene così al popolo, non allo Stato o alla Nazione: l'apparato ne è lo strumento, secondo i modelli della democrazia rappresentativa che elegge i rappresentanti in seno alle Camere e designa gli ulteriori organi (primo fra tutti il Governo) e della democrazia diretta, cioè della partecipazione attiva dei cittadini in varie forme: archetipo è il referendum abrogativo di cui all'art. art. 75 Cost.
3. Il Principio Di Uguaglianza
L’articolo 3 della Costituzione, al 1° comma, stabilisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali: si tratta del principio di uguaglianza formale, che costituisce la regola fondamentale dello Stato di diritto.
Il principio de quo comporta due fondamentali conseguenze:
- tutti sono uguali davanti alla legge, a prescindere della condizione sociale o dal ruolo svolto;
- il legislatore non può approvare leggi che contengono discriminazioni fondate sul sesso, sulla razza, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche, sulle condizioni personali e sociali.
Nel caso lo facesse, le leggi sarebbero annullate dalla Corte costituzionale.
Il divieto di discriminazione non deve essere inteso, però, in senso assoluto, dal momento che la stessa Costituzione prevede misure a favore di particolari categorie. Esempi ne sono l’articolo 6 Cost., che impone alla Repubblica di tutelare con apposite norme le minoranze linguistiche, e l’art. 51 Cost., il quale prevede l’adozione di provvedimenti per promuovere le pari opportunità tra donne e uomini.
Il principio di uguaglianza vieta, quindi, solo le discriminazioni irragionevoli. In questo senso si dice che il principio in esame si evolve in principio di ragionevolezza.
Il principio di uguaglianza formale resterebbe, così una pura enunciazione teorica se non fosse integrato dall’impegno pratico dello Stato nel creare le condizioni di uguaglianza sostanziale. Per tale motivo, il comma 2 dell’art. 3 Cost. affida alla Repubblica il compito di intervenire per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, affinchè tutti i cittadini siano posti inizialmente su un piano di sostanziale parità e godano di determinate utilità sociali (quali l’istruzione, la salute, il lavoro), della possibilità di dare pieno sviluppo alla propria persona e di partecipare alla gestione del Paese.
4. I Diritti Della Costituzione Italiana
I diritti inviolabili della persona
Con l’espressione “diritti inviolabili” s’intendono quei diritti e quelle libertà essenziali che costituiscono la base e il fondamento del nostro regime politico.
L’articolo 2 della Costituzione stabilisce che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”
Con ciò si sono posti a fondamento del nostro ordinamento i principi personalista, pluralista e solidarista, già peraltro impliciti nel più comprensivo principio democratico, in forza dell’art. 1 Cost.
Dal principio personalista discende che fine ultimo dell’organizzazione sociale è lo sviluppo di ogni singola persona umana e che di conseguenza non è la persona in funzione dello Stato, ma lo Stato in funzione della persona.
Pertanto, il “riconoscimento” da parte della Repubblica dei diritti inviolabili dell’uomo sta a significare che tali diritti sono anteriori rispetto all’ordinamento giuridico e, quindi, non sono nella disponibilità dello Stato, che non può né comprimerli né disconoscerli.
Inoltre, tali diritti sono indispensabili ed intrasmissibili (non possono cioè essere oggetto di rinunzia o transazione) da parte dei loro titolari e sono imprescrittibili (non si estinguono nonostante il mancato esercizio da parte del titolare).
L’art. 2 Cost., poi, chiama in causa la Repubblica, intesa come Stato – ordinamento o Stato – istituzione, comprensivo cioè non solo dello Stato – soggetto, ma anche degli ordinamenti politici esistenti (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) e si riferisce sia ai cittadini che agli stranieri, relativamente tanto ai diritti che ai doveri.
Come si evince da un’interpretazione letterale della norma, i diritti inviolabili sono riconosciuti all’uomo sia come singolo (diritto al nome, alla libertà di manifestazione del proprio pensiero), sia come membro di formazioni sociali (diritto di associazione e di riunione).
Infine, l’art. 2 Cost. garantisce tali diritti anche alle formazioni sociali, quali ad es. la famiglia e i partiti politici, che costituiscono il collegamento tra le istituzioni e il cittadino e che rendono possibile lo sviluppo della persona e la sua partecipazione alla vita sociale, politica ed economica del Paese.
Individuazione dei diritti inviolabili
Nell’individuazione dei diritti inviolabili sono state prospettare due tesi:
- una prima tesi vede nell’art. 2 Cost. una norma “a fattispecie chiusa”, nel senso di costituire una sintesi dei diritti espressamente riconosciuti da altre disposizioni costituzionali;
- ed una seconda tesi, più articolata ed ampliativa, che intravede nell’immediata inerenza di altre situazioni giuridiche ai valori propri della persona umana la possibilità di includere tali situazioni tra i diritti inviolabili (tesi della norma costituzionale come “fattispecie aperta”).
Dottrina e giurisprudenza hanno ritenuto più corretto ritenere che l’art. 2 Cost. costituisce nel disegno costituzionale la norma generale che riconosce e garantisce i diritti inviolabili, i quali non sono soltanto quelli qualificati tali dalla stessa Carta costituzionale, ma sono comprensivi di ulteriori diritti. Questi ultimi sono anch’essi inviolabili e si ricavano dall’interpretazione sistematica ed evoluta delle disposizioni costituzionali che li riguardano e che rispondono alla realizzazione, nei vari stadi della nostra civiltà, del libero e pieno sviluppo della persona umana.
Dal principio del primato della persona umana discende, inoltre, che ai detenuti vanno riconosciuti, al pari di tutti i cittadini, i diritti fondamentali compatibili con la detenzione.
In applicazione dello stesso principio la Carta Costituzionale non ammette la pena di morte e proprio da tale divieto si trae il diritto inviolabile alla vita di ogni persona.
5. I Rapporti Civili
La libertà personale
Apre il catalogo delle libertà costituzionali la libertà personale, ex art. 13 Cost., il quale costituisce il presupposto logico e giuridico di tutte le libertà riconosciute all’individuo della Costituzione.
La libertà in esame non è solo da intendersi come fisica, ma anche morale e, quindi, libertà non solo della coercizione fisica, ma anche da ogni forma di coercizione della volontà, del pensiero e della psiche dell’individuo.
Il fondamento costituzionale della libertà personale dell’individuo, oltre che nell’art. 13 Cost., deve ravvisarsi anche nell’art. 23 Cost., secondo il quale “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.
Il diritto de quo è un diritto inviolabile e, in quanto diritto della personalità, presenta i seguenti caratteri:
A tutela della libertà personale la disposizione costituzionale fa ricorso agli strumenti della riserva di legge (assoluta), della riserva di giurisdizione e della motivazione obbligatoria dell’atto.
La norma in esame, dopo aver dichiarato l’inviolabilità della libertà personale, afferma che “Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”.
Rientra nell’ambito del principio personalistico, di cui la libertà personale è espressione, il diritto dell’individuo all’identità personale, sotto il profilo del diritto al nome, primo e più immediato segno distintivo, parte essenziale e irrinunciabile della personalità e in quanto tale appartenente al novero di quei diritti, definiti inviolabili, protetti dall’art. 2 Cost.
La disposizione in commento si occupa, inoltre, del trattamento del detenuto, prevedendo una duplice garanzia:
- è indisponibile da parte del titolare;
- è intrasferibile, sono nulle le convenzioni con cui un soggetto trasferisca ad altri il diritto alla sua libertà personale;
- è irrinunciabile, sono annullabili gli atti che costituiscono rinuncia a tale diritto;
- è imprescrittibile, il diritto non si estingue nonostante il mancato esercizio protratto per un determinato tempo;
- è tutelato nei confronti di tutti e, quindi, ha carattere assoluto.
- la prima, prevista dal penultimo comma dell’art. 13 Cost., riguarda le persone comunque sottoposte a restrizione della libertà personale e consiste nel divieto su di esse di “ogni violenza fisica o morale”;
- mentre, la seconda riguarda chi è sottoposto a pena: le pene, dice l’art. 27, c.3, Cost., non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
La libertà di domicilio
Anche la libertà di domicilio, disciplinata dall’art. 14 Cost., costituisce un diritto soggettivo inviolabile.
Il domicilio cui fa riferimento il disposto costituzionale è il luogo in cui l’individuo localizza gli elementi essenziali della propria persona e agisce con una libertà di comportamento che spesso può ignorare i limiti delle norme di convivenza.
La disposizione costituzionale tutela il domicilio sotto due distinti aspetti: come diritto di ammettere o escludere altre persone da determinati luoghi, in cui si svolge la vita intima di ciascun individuo e come diritto alla riservatezza su quanto si compie nei medesimi luoghi.
Titolari di tale diritto di libertà sono, oltre i cittadini anche gli stranieri e gli apolidi, nonché le associazioni.
La libertà e la segretezza della corrispondenza
L’art. 15 Cost. sancisce l’inviolabilità della libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, a garanzia della riservatezza contro abusive interferenze.
Tale corrispondenza deve, ormai, intendersi nel senso più ampio ricomprendendo anche la moderna tecnologia.
La libertà in parola si configura come diritto soggettivo perfetto e come diritto alla riservatezza, riconosciuto come connaturale ai diritti della personalità definiti inviolabili dall’art. 2 Cost.
In riferimento all’art. 2 Cost., il diritto ad una comunicazione libera e segreta è inviolabile, nel senso che il suo contenuto essenziale non può essere oggetto di revisione costituzionale, in quanto incorpora un valore della personalità avente un carattere fondante rispetto al sistema democratico voluto dal Costituente.
In base all’art. 15 Cost., lo stesso diritto è inviolabile nel senso che il suo contenuto di valore non può subire restrizioni e limitazioni da alcuno dei poteri costitutivi se non in ragione dell’inderogabile soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante, semprechè l’intervento limitativo posto in essere sia strettamente necessario alla tutela di quell’interesse e sia rispettata la duplice garanzia che la disciplina prevista risponda ai requisiti propri della riserva assoluta di legge e la misura limitativa sia disposta con atto motivato dall’autorità giudiziaria.
La libertà di circolazione e soggiorno, la libertà di espatrio e la libertà di emigrazione
Il diritto garantito dall’art. 16 Cost. si estrinseca in tre facoltà: libertà di circolazione, libertà di soggiorno e libertà di espatrio.
Sia la libertà di circolazione all’interno del nostro territorio che la libertà di espatriare creano nel soggetto un vero e proprio diritto soggettivo e per ambedue le limitazioni consentite non possono che essere poste dalla legge (riserva assoluta di legge) e per giunta, per quelle relative alla libertà di circolazione, dalla legge in via generale e per motivi di sanità e di sicurezza (c.d. riserva di legge rinforzata).
La libertà di soggiorno si concretizza nel diritto di fissare o anche trasferire la propria residenza o il proprio domicilio in qualsiasi parte del territorio nazionale, compresa la scelta del luogo di lavoro.
Infine, quale aspetto della libertà di espatrio, l’ultimo comma dell’art. 35 Cost. prevede la libertà di emigrazione, quale diritto fondamentale dettato a favore di coloro che si recano all’estero in cerca di lavoro.
Anche per tale libertà è previsto il limite degli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale.
La libertà di riunione
L’art. 17 Cost. riconosce ai cittadini “il diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi” (comma 1), precisando che le riunioni “possono essere vietate solo per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica” (comma 2 e 3).
Il disposto costituzionale va messo in correlazione con l’art. 2 Cost. e con l’art. 3 Cost., trattandosi di un mezzo che meglio consente ai cittadini di sviluppare la loro personalità e di operare efficacemente.
Si tratta di una libertà a carattere collettivo riconosciuta a tutti coloro che volontariamente si ritrovano in uno stesso luogo per qualsiasi scopo (culturale, di divertimento, per motivi religiosi, ecc.).
In essa vi rientrano, quindi, cortei, le processioni religiose, le rappresentazioni, gli spettacoli organizzati privatamente, i convegni, le assemblee, i comizi.
Quanto al regime giuridico delle riunioni, la Costituzione distingue le riunioni in private, aperte al pubblico e pubbliche, richiedendo preavviso all’autorità di pubblica sicurezza soltanto per queste ultime per evidenti motivi di ordine pubblico.
Il preavviso va dato, almeno tre giorni prima della riunione, dai promotori della stessa al questore, in forma scritta, con l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo della riunione e l’oggetto della stessa.
Nel caso di riunioni pubbliche, non è causa di scioglimento delle stesse l’eventuale presenza di qualche soggetto armato che, se mai, va immediatamente allontanato.
La libertà di associazione
La Costituzione all’art. 18garantisce ai cittadini il “diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale” (comma 1), vietando espressamente solo “le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare” (comma 2).
L’associazione si differenzia dalla riunione in quanto caratterizzata:
- da una stabile e duratura organizzazione;
- dall’esistenza di un vincolo permanente tra gli associati;
- dall’esistenza di uno scopo comune da perseguire.
La libertà di associazione è, come la libertà di riunione, una libertà strumentale. La Costituzione, infatti, garantisce la libertà in esame poiché considera quest’ultima come una libertà indispensabile per favorire lo sviluppo della persona e la sua partecipazione alla vita economica, politica e sociale del Paese.
Rientra nella tutela costituzionale non solo il diritto di costituire liberamente associazioni, o di aderire a quelle esistenti, ma anche di recedere da quelle a cui si è aderito e di non associarsi.
Espressione della libertà di associazione sono i partiti politici e le associazioni sindacali.
Del sindacato ci si occuperà nell’ambito dei rapporti economici.
Quanto ai partiti politici è all’art. 49 Cost. che bisogna far riferimento, il quale riconosce il diritto di tutti i cittadini di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
Più precisamente, i partiti politici costituiscono l’anello di congiunzione fra le istituzioni rappresentative e la volontà popolare: sono associazioni di persone con comunanza di ideologia e di interessi che, attraverso una stabile organizzazione, mirano ad influenzare la determinazione dell’indirizzo politico del paese.
L’unico requisito imposto dalla Costituzione ai partiti politici è che, a prescindere dai fini perseguiti, l’attività di partito sia rispettosa del “metodo democratico”, ossia di quelle regole che disciplinano il funzionamento di qualsiasi formazione a base democratica. L’unica eccezione alla libertà d’associazione politica è quella rappresentata dal divieto di ricostituire il partito fascista.
Inoltre, i partiti politici, essendo espressione della libertà di associazione, non possono assumere la forma di associazione segreta, né presentare carattere di organizzazione militare, né assumere simboli o contrassegni suscettibili di confondersi con simboli altrui o che riproducano immagini religiose.
Infine, i partiti non possono annoverare tra i loro iscritti particolari categorie di cittadini, come i militari di carriera in servizio permanente in servizio, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i magistrati, i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero.
La libertà religiosa, la libertà di religione e la libertà di coscienza
L’Italia è uno Stato laico e riconosce la libertà religiosa a tutti (cittadini, stranieri e apolidi), senza alcuna discriminazione.
Ciò spiega, perché, oltre all’eguaglianza in materia (art. 8 Cost.) è garantita anche la libertà di fede religiosa dall’art. 19 Cost.
In concreto tale libertà consiste nella possibilità di scegliere il proprio credo religioso, divulgandolo con opere di proselitismo ed esercitandone il culto; nella libertà di non essere costretti a professare una particolare fede religiosa; nella libertà di non essere costretti a professare una particolare fede religiosa; nella libertà di non avere un proprio credo religioso, cd. libertà di ateismo.
Unico limite in materia è costituito dal fatto che gli atti di culto non devono essere contrari al buon costume, cioè non devono concretizzarsi in manifestazioni contrarie alla morale corrente.
Quanto ai rapporti fra lo Stato italiano e le confessioni religiose, per le confessioni acattoliche la disciplina è dettata dalla legge ordinaria sulla base di intese con le relative rappresentanze; per quanto riguarda, invece, i rapporti con la Chiesa cattolica l’articolo 7 della Costituzione fa riferimento ai Patti Lateranensi del 1929 (poi modificati nel 1984), le cui modifiche devono essere accettate da entrambe le parti.
Il diverso rilievo è giustificato dallo storico radicalismo del cattolicesimo in Italia, oltre che dalla presenza dello Stato Vaticano nella citta di Roma.
La libertà di manifestazione del pensiero
L’art. 21 Cost., al suo 1° comma, garantisce sia la manifestazione che la divulgazione del proprio pensiero “con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”.
La libertà in oggetto è tra le libertà fondamentali proclamate e protette dalla Costituzione, quella che meglio caratterizza il vigente ordinamento democratico.
Le limitazioni sostanziali di tale libertà non possono essere poste se non per legge (riserva assoluta di legge) e devono trovare fondamento in precetti e principi costituzionali.
E’ evidente la differenza tra la libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di comunicazione, differenza che non si attiene al contenuto del pensiero espresso, bensì nelle modalità prescelte per esternarlo, tutelandosi con l’art. 15 Cost. il diritto alla riservatezza e con l’art. 21 Cost. la libertà delle pubbliche esternazioni.
Titolari di tale diritto sono tutti i cittadini, ancorchè minori, gli stranieri e le formazioni sociali.
Quanto ai contenuti di tale libertà, si ritiene che la norma de qua garantisce ad ogni individuo la facoltà di esternare il proprio pensiero. Il che non significa che vi sia un divieto costituzionale di manifestare il pensiero altrui, ma soltanto che la disciplina di tale manifestazione è lasciata al legislatore ordinario.
La tutela costituzionale di cui all’art. 21 Cost. non copre soltanto la libertà di manifestare il proprio pensiero, libertà positiva, ma anche la libertà di tacere o di astenersi da tale manifestazione, c.d. diritto al silenzio.
La libertà in parola comprende tre posizioni giuridiche soggettive, tra loro distinte, corrispondenti al diritto di “cercare, riceve e diffondere informazioni” riconosciuto ad ogni individuo dall’art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 e cioè il diritto di informarsi, il diritto ad essere informati e il diritto di informare.
Solo quest’ultimo diritto può farsi rientrare nella libertà di manifestazione del proprio pensiero “con ogni altro mezzo di diffusione”. Per gli altri due, invece, occorre far riferimento, oltre che all’art. 21 Cost., alle altre disposizioni costituzionali che garantiscono il pieno sviluppo della persona (art. 2, c.3, Cost.), l’eguaglianza (art. 3 Cost.), la sovranità popolare (art.1, c.2, Cost.) e la partecipazione popolare all’organizzazione del Paese (art.3, c.2, Cost.).
Nella libertà (o diritto) di informare si fa rientrare il diritto di cronaca, che incontrerebbe un limite nei cc.dd. diritti della personalità, ovvero nei diritti alla riservatezza, all’onore, alla reputazione, alla dignità sociale.
L’ultimo comma della disposizione in esame stabilisce come unico limite il “buon costume”, inteso, dalla giurisprudenza costituzionale, come un insieme di precetti che impongono un determinato comportamento nella vita sociale, la cui inosservanza comporta la violazione del pudore sessuale. Di recente la Corte costituzionale ha ritenuto che contenuto minimo di tale limite è da rinvenire non solo in ciò che è comune alle diverse morali del nostro tempo, ma anche nella pluralità delle concezioni etiche che convivono nella società contemporanea.
Uno dei più importanti ed incisivi mezzi di manifestazione del pensiero è la stampa. L’art. 21 Cost. sancisce in materia i seguenti principi:
- esclusione di ogni forma di autorizzazione preventiva. Infatti chi intende pubblicare un libro o uno stampato non deve chiedere alcun consenso preventivo per poterlo diffondere;
- esclusione di ogni forma di censura;
- disciplina legislativa delle ipotesi di sequestro dello stampato;
- possibilità di stabilire con legge dei controlli sui mezzi di finanziamento della stampa periodica;
facoltà del legislatore di adottare controlli preventivi e mezzi repressivi contro la stampa che offenda il buon costume.
6. I Rapporti Etico-Sociali
La tutela della famiglia
La Carta Costituzionale si preoccupa anche di garantire i diritti sociali collegati all’appartenenza dell’individuo a determinate formazioni sociali, cui si svolge la sua personalità.
La prima di queste è la famiglia, quale “società naturale fondata sul matrimonio” ex art. 29 Cost.
Più specificamente, la famiglia è intesa come realtà sociale e giuridica, che presuppone, oltre un’assoluta parità morale e giuridica, l’esistenza e la permanenza della comunione spirituale e materiale tra i componenti del nucleo essenziale.
Inoltre, la Costituzione fa riferimento alla famiglia fondata sul matrimonio, i cui diritti sono in gran parte stabiliti dal Codice Civile (artt. 143 -160 c.c.) e vanno dalla libertà di contrarre matrimonio, al diritto di procreare, al diritto di coabitazione, al diritto –dovere all’assistenza morale e materiale dei membri della famiglia, al diritto all’educazione familiare (che comprende il diritto – dovere dei genitori di formare i propri figli e di assicurarne il pieno sviluppo della personalità e corrispondentemente il diritto dei figli, sia legittimi che naturali, di ricevere un’educazione).
Rientrano tra le formazioni sociali, di cui all’art. 2 Cost., anche le convivenze di fatto, sia eterosessuali che omosessuali, nonché le cd. famiglie monoparentali.
Da ultimo, con la l. 76/2016, quasi l’intera disciplina del diritto di famiglia è stata estesa alle unioni civili, ossia a tutte quelle forme di convivenza di coppia, basata su vincoli affettivi ed economici, alla quale la legge riconosce attraverso uno specifico istituto giuridico uno status giuridico analogo, per molti aspetti, a quello conferito dal matrimonio.
La cultura e la scuola
L’art. 9 del dettato costituzionale stabilisce che “la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico ed artistico della Nazione”.
La Costituzione prevede, quindi, per lo Stato l’impegno di intervenire per promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e, attraverso di esse, la crescita dell’individuo, nella consapevolezza che non si può assistere a nessun progresso sociale ed umano senza crescita culturale.
Una specifica applicazione della promozione della cultura è rappresentata dagli artt. 33 – 34 Cost., che disciplinano la materia dell’istruzione scolastica secondo i seguenti principi:
- il principio della libertà di insegnamento; il principio della presenza di scuole statali per tutti i tipi, ordini e gradi dell’istruzione;
- il principio del libero accesso all’istruzione scolastica, senza alcuna discriminazione tra cittadini e stranieri. In tal modo si realizza quella basilare garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo “nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” (art. 2 Cost.);
- il principio dell’obbligatorietà e gratuità dell’istruzione dell’obbligo;
- il riconoscimento del diritto allo studio anche a coloro che sono privi di mezzi, purchè capaci e meritevoli mediante borse di studio, assegni familiari ed altre provvidenze;
- il principio dell’ammissione per esami ai vari gradi dell’istruzione scolastica e dell’abilitazione professionale per esami (art. 33, c. 5, Cost.); il principio della libera istituzione di scuole da parte di enti privati, sia laici che religiosi, cd. pluralismo scolastico, conseguente al riconosciuto principio del pluralismo degli insegnanti, che incontra il solo limite del buon costume.;
- il principio della possibilità di parificazione delle scuole private e pubbliche, quanto agli effetti legali e al riconoscimento professionale del titolo di studio, ma nel rispetto di certe condizioni che la Costituzione riserva al legislatore ordinario e senza oneri per lo Stato.
Tra la famiglia e la scuola, relativamente alla formazione dei minori e dei giovani, va instaurato un rapporto di collaborazione e di integrazione reciproca, nel senso che mentre alla famiglia compete la formazione totale (educazione) dei fanciulli, alla scuola è affidata l’istruzione di questi ultimi. In particolare, l’istituzione scolastica, insegna le conoscenze e le tecniche dirette a sviluppare le capacità intellettive, artistiche e pratiche dei singoli, necessarie per la vita di relazione, ma nel rispetto dei valori e delle credenze fondamentali emersi o emergenti nel processo di interazione del minore stesso con la propria famiglia.
Il diritto all’istruzione, quale diritto sociale, comprende, dal lato attivo, il diritto di istruire e, dal lato passivo, il diritto di ricevere un’istruzione.
Il primo a sua volta si articola nella libertà di insegnamento e nella libertà di istituire e gestire scuole ed istituti di educazione, cd. libertà della scuola; mentre, il diritto all’istruzione si presenta come libertà di scelta della scuola e come diritto di ricevere un insegnamento.
Il diritto alla salute e a trattamenti sanitari
Il bene della salute è tutelato dall’art. 32, c.1, Cost., sia come fondamentale diritto dell’individuo sia come interesse della collettività.
Sotto il primo profilo esso va considerato come un diritto primario e fondamentale, come un diritto erga omnes, che, in quanto tale, impone piena ed esaustiva tutela.
Come interesse della collettività, invece, il diritto alla salute, secondo alcuni autori della dottrina, si tradurrebbe nel diritto ad un ambiente salubre. Ma, secondo la giurisprudenza costituzionale e una parte della dottrina, la tutela di tale diritto deriverebbe dalla confluenza unitaria di tre fondamentali componenti, costituiti principalmente da interessi protetti dalla Costituzione come beni collettivi, quali: la tutela del paesaggio, la salute come interesse della collettività e il diritto individuale alla salute.
Tale diritto si presenta, quindi, di natura complessa, comprendendo sia diritti collettivi che diritti individuali, tanto che, in sede legislativa, i primi sono configurati come interessi diffusi riferiti ad una collettività e solo quando le attività nocive e pericolose riguardano singole persone ci si trova di fronte al diritto alla salute.
Come diritto individuale, il diritto de quo comprenderebbe non solo l’integrità fisica, di cui all’art. 5 c.c., ma anche l’integrità e l’equilibrio psico-fisico nel suo complesso dell’individuo, atteggiandosi, quindi, come diritto alla salute mentale.
Nell’ambito dell’art. 32 Cost., attraverso un’interpretazione congiunta del 1° e 2° comma del disposto costituzionale, si fa rientrare il cd. diritto a trattamenti sanitari, comprensivo di ogni attività terapeutica e diagnostica diretta a prevenire e curare malattie. In particolare, lo stesso articolo in esame, al comma 1, riconosce agli indigenti il diritto a cure gratuite e, dal 2° comma della stessa norma, dispone che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Si desume a contrario il diritto del singolo alla scelta dei trattamenti sanitari cui sottoporsi.
Strettamente collegato alla scelta del trattamento sanitario è la questione del consenso informato del paziente ai trattamenti medici e sanitari, qual espressione della consapevole adesione a questi ultimi. In tal caso, si configura un vero e proprio diritto della persona che trova fondamento nei principi espressi nell’art. 2 Cost., il quale ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 Cost., che stabiliscono, rispettivamente, che “la libertà personale è inviolabile” e che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge”.
 Il diritto costituzionale nella giurisprudenza,
di Morrone Andrea, Ed. CEDAM. Il volume raccoglie un’antologia di casi
di giurisprudenza, italiana e straniera, su questioni di diritto
costituzionale, organizzata per temi generali (principi, diritti
fondamentali, fonti del diritto, poteri dello stato, giustizia
costituzionale). Il diritto costituzionale nella giurisprudenza,
di Morrone Andrea, Ed. CEDAM. Il volume raccoglie un’antologia di casi
di giurisprudenza, italiana e straniera, su questioni di diritto
costituzionale, organizzata per temi generali (principi, diritti
fondamentali, fonti del diritto, poteri dello stato, giustizia
costituzionale).Scarica gratuitamente l'indice |
7. I Rapporti Economici
Il lavoro
La Costituzione considera il lavoro come il più importante fenomeno della vita sociale, affermando, all’articolo 1 della Carta costituzionale, che “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”.
Si tratta del principio lavoristico che fa del lavoro il fondamento stesso della Repubblica, che si estende ad ogni forma di attività economica produttiva e che non può essere modificato neppure tramite il procedimento di revisione costituzionale previsto dall’art. 138 Cost.
Il comma 1 dell’art. 4 Cost. afferma che “la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”.
Tale norma attribuisce ad ogni cittadino la libertà di scegliere quale attività lavorativa svolgere, imponendo nel contempo allo Stato di promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro.
Anche se la norma sancisce un impegno generico a carico dello Stato di perseguire una politica di pieno impegno per combattere la disoccupazione, esso non può considerarsi solo una norma programmatica, ma è una norma immediatamente precettiva poiché permette e giustifica l’intervento dello Stato nel sistema economico, allo scopo di raggiungere il livello di piena occupazione.
I diritti dei lavoratori
I principi costituzionali dettati a tutela del lavoro e dei lavoratori sono:
- il diritto del lavoratore ad una retribuzione “proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa” (art. 36, c.1, Cost.);
- il diritto del lavoratore al riposo giornaliero, al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite (art. 36, c. 2 e 3, Cost.), e ciò allo scopo di proteggerne le energie psico –fisiche e consentire il loro recupero;
- parità tra uomo e donna in materia di lavoro: l’art. 37, c.1, Cost., attribuisce alla donna lavoratrice gli stessi diritti e, a parità di lavoro, la stessa retribuzione che spetta all’uomo, ma anche il diritto a che le siano assicurate condizioni di lavoro tali da consentirle l’adempimento della sua essenziale funzione familiare ed una speciale adeguata protezione, affinchè possa svolgere, se del caso, nel disimpegno dell’attività di lavoro, anche il compito di madre;
- diritto al mantenimento e all’assistenza sociale dei cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere (art. 38, c.1, Cost.). Si tratta di disposti costituzionali fondati sulla solidarietà collettiva aventi immediata precettività;
- diritto dei lavoratori, in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria, alla previdenza e all’assistenza sociale (art. 38, c.2, Cost.);
- diritto dei lavoratori alla collaborazione e alla gestione delle aziende, al fine dell’elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione (art. 46 Cost.).
La libertà sindacale
Il sindacato nasce a tutela dei diritti dei lavoratori allo scopo di migliorarne le condizioni di vita e di lavoro.
La nostra Carta costituzionale proclama all’art. 39, da un lato, la libertà di organizzazione sindacale, e cioè la libertà dei lavoratori di organizzarsi liberamente in sindacati senza alcuna speciale autorizzazione da parte dello Stato, e dall’altro garantisce ai sindacati il diritto di agire nell’interesse dei lavoratori.
A questa garanzia si accompagna, sempre per i sindacati, quella di autogovernarsi e di liberamente autodeterminarsi con un ordinamento interno a base democratica per il conseguimento dei fini propri dell’organizzazione stessa.
Infine, sempre dalla disposizione de qua si trae il principio della liceità della pluralità sindacale, ossia della libertà di costituire più organizzazioni sindacali nell’ambito di una stessa categoria e settore economico, qualunque sia il metodo di organizzazione o di raggruppamento seguito.
La funzione fondamentale dei sindacati è quella di stipulare nell’interesse dei lavoratori contratti collettivi di lavoro.
I sindacati vanno inquadrati nella categoria delle associazioni non riconosciute, con la conseguenza che essi possono stipulare contratti collettivi di diritto che hanno efficacia vincolante solo per i propri iscritti, anche se di fatto oggi i contenuti minimi inderogabili dei contratti stessi vengono estesi a tutti i contratti stipulati per quel settore.
Infine, il ruolo del sindacato si estende anche allo svolgimento, in favore dei propri iscritti, di un’opera di promozione civile, di sostegno delle rivendicazioni, di assistenza nelle controversie.
Il diritto di sciopero e la serrata
Il principale strumento di lotta sindacale volto al soddisfacimento delle rivendicazioni dei lavoratori è costituito dallo sciopero (art. 40 Cost.).
Esso consiste nell’astensione concreta dal lavoro per la tutela di un interesse professionale collettivo e rappresenta una forma di autotutela, riconosciuta e garantita dalla Costituzione.
Si possono avere astensioni totali dal lavoro, ma anche forme particolari di astensione, come ad es.:
- gli scioperi a singhiozzo, dove a periodi brevi di astensione seguono altrettanto periodi brevi di lavoro;
- gli scioperi a scacchiera, dove l’astensione, nell’ambito di un settore produttivo articolato in reparti tra loro interconnessi, è proclamato da un reparto, e non da tutti, in modo da bloccare ugualmente il lavoro dell’intero settore;
- gli scioperi bianchi, dove non vi è una vera e propria astensione dal lavoro ma un rallentamento dello stesso a seguito di una applicazione pedissequa delle disposizioni di legge dettate per l’attività cui i dipendenti sono preposti.
Inoltre, allo sciopero si può far legittimamente ricorso non solo per il conseguimento di fini di carattere economico e retributivo, ma anche per tutte le rivendicazioni riguardanti il complesso degli interessi dei lavoratori, attraverso anche la richiesta di emanare o non emanare atti di governo o atti legislativi, venendo così ad influire sulle deliberazioni delle autorità pubbliche: si tratta dei cc.dd. scioperi politici.
La libertà di sciopero, tuttavia, deve svolgersi in modo da non ledere altre libertà costituzionalmente garantite, come ad es. la libertà di lavoro a tutti coloro che non aderiscono allo sciopero.
Il diritto in esame è stato riconosciuto legittimo anche se implica l’interruzione di servizi pubblici, a meno che non si tratti di servizi il cui funzionamento sia da considerarsi essenziale, e cioè indispensabile alla collettività.
Sono considerati servizi pubblici essenziali quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione e alla libertà di comunicazione.
Nell’ambito di tali servizi il diritto di sciopero va esercitato nel rispetto di misure atte a consentire l’erogazione di prestazioni indispensabili o minime a tutela dei diritti di cui si è detto, attraverso procedimenti che consentono di conoscere in anticipo, a mezzo di preavviso non inferiore a dieci giorni, la durata dell’astensione.
Anche gli imprenditori possono utilizzare uno strumento di protesta e di lotta sostanzialmente collettiva costituito dalla serrata, ovvero dalla sospensione dell’attività produttiva diretta a indurre i lavoratori ad accettare o la modifica dei preesistenti contratti collettivi (cd. serrata offensiva) o soluzioni di compromesso rispetto alle pretese avanzate (cd. serrata difensiva).
La libertà di iniziativa economica
Il complesso delle disposizioni costituzionali contenute negli artt. 41-47costituiscono la cd. costituzione economica.
In particolare, bisogna soffermare l’attenzione sulla libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), quale libertà dei privati di scelta e di svolgimento delle attività economiche senza interventi pubblici che la restringano in modo arbitrario.
Al riconoscimento della libertà in parola seguono le limitazioni alla stessa libertà dettate dal 2° e del 3° comma dell’art. 41 Cost.: l’iniziativa economica privata, comunque essa si manifesti “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.
Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale limitazioni per ragioni di “utilità sociale”, possono essere legittimamente dettate dalla legge, ad es., a tutela della pubblica salute o delle bellezze naturali o ponendo limiti contrattuali alla concorrenza; ciò in quanto si tratta di una clausola a carattere generale e flessibile.
Inoltre, la libertà economica privata non può estrinsecarsi in attività nocive all’incolumità dei cittadini o che importino umiliazione o sfruttamento dei lavoratori.
Infine, la disposizione in commento al suo 3° comma autorizza il legislatore a stabilire programmi e controlli, allo scopo di indirizzare l’attività economica privata “a fini sociali”: programmi e controlli che però non possono sopprimere l’iniziativa individuale, ma possono soltanto indirizzarla e coordinarla.
8. Il Principio Del Pluralismo Territoriale
L’art. 5 della Carta Costituzionale enuncia il principio del pluralismo territoriale, ovvero il riconoscimento di centri di potere autonomi, più vicino al cittadino, in un'ottica di c.d. sussidiarietà verticale.
In tal modo, oltre al principio di unità ed indivisibilità della Repubblica, si afferma il principio di decentramento dei poteri, della promozione e del riconoscimento della autonomie locali.
In particolare, la norma in commento enuclea quattro principi fondamentali:
- l'unita ed indivisibilità della Repubblica;
- la promozione ed il riconoscimento della autonomie locali;
- l'attuazione del più ampio decentramento amministrativo nell'erogazione dei servizi;
- lo Stato deve adeguare le proprie leggi alle esigenze dell'autonomia e del decentramento, mediante la creazione e la tutela di enti territoriali espressione dello Stato comunità.
Il decentramento e l'autonomia sono infatti complementari tra loro. Lo sviluppo delle autonomie territoriali garantisce anche un importante decentramento di funzioni, mentre il decentramento amministrativo consente di avvicinare i servizi erogati e le funzioni ai destinatari di essi. Nondimeno, lo Stato è comunque da considerarsi l'Ente pubblico sovrano per eccellenza.
9. Le Minoranze Lingustiche
E’ l’art. 6 Cost. che fa carico alla Repubblica di tutelare con apposite norme le minoranze linguistiche.
Tale norma, oltre ad impedire qualsiasi forma di discriminazione basata sull'appartenenza a minoranze linguistiche, dispone anche una tutela positiva, con lo scopo di conservare il patrimonio linguistico e culturale di tali minoranze.
In ogni caso, ciò non toglie che, in ossequio al principio di unitarietà dello Stato, l'uso della lingua italiana goda del primato rispetto alle altre lingue.
Raccordandosi idealmente all'art.3 Cost., e completandone l'ideale di pluralismo differenziato, la disposizione in commento conferisce il potere di tutela ai vari enti purchè rispettino l'eterogeneità dimensionale, di radicamento, e di storia. Viene così sottinteso un modello di proporzionalità allo scopo nel trattamento positivo di tali situazioni linguistico/culturali specifiche.
Le svariate forme di tutela spaziano dalla negoziazione normativa (strumento principe) a quella provvedimentale (in ambito amministrativo quindi), sino alla rappresentanza istituzionale del gruppo (come avviene nel Trentino-Alto Adige). Ruolo fondamentale gioca la legge n. 482 del 1999, che opera tramite determinati Comitati ed a livello di scuole, università, amministrazioni pubbliche (come anche in ambito di giustizia). Non viene messo in dubbio, peraltro, il semplice fatto che la lingua ufficiale della Repubblica resti l'italiano, perlomeno nelle circostanze "ufficiali" come assemblee elettive, anagrafe, istruzione scolastica, toponomastica e mass media.
10. La Tutela Dello Straniero
All'interno dell'ordinamento giuridico italiano la condizione giuridica dello straniero viene disciplinata sia dalla carta costituzionale che dalla legge ordinaria.
Il comma due dell’art. 10 Cost. delega infatti la legislazione ordinaria a regolare tale condizione in conformità alle norme ed ai trattati internazionali.
Il comma tre della norma de qua statuisce, invece, che lo straniero al quale sia impedito l'effettivo esercizio, nel suo Paese d'origine, delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiane, ha diritto d'asilo nel territorio italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Infine, per quanto concerne il comma quattro della medesima disposizione, esso vieta l'estradizione per motivi politici.
Si può dunque distinguere tra:
- rifugiato politico, vale a dire chi vive nel fondato timore di venir perseguitato per motivi di razza, religione, cittadinanza, appartenenza ad un determinato gruppo;
- richiedente asilo, ovvero la persona che non chiede solamente il soggiorno, bensì anche la protezione, per essersi egli sottratto agli organi di giustizia del Paese d'origine;
- profugo, fuggito per motivi legati alla guerra, alla persecuzione o a calamità naturali.
La condizione giuridica dello straniero residente in Italia è protetta dalla previsione di una riserva rafforzata di legge: il trattamento giuridico a cui viene sottoposto non viene lasciato all'arbitrio della pubblica amministrazione, ma può essere fissato soltanto dalla legge e non può essere meno favorevole di quanto previsto nelle norme di diritto internazionale, sia consuetudinarie, sia pattizie.
Ciò non esclude che il legislatore italiano possa sopravanzare il diritto internazionale nel predisporre un trattamento più favorevole, ponendosi, così, a modello di riferimento per la comunità internazionale.
Attualmente esistono nel nostro ordinamento due categorie di stranieri:
- i cittadini dell'Unione europea, che godono di una tutela particolarmente qualificata e tendenzialmente assimilabile a quella riconosciuta agli italiani;
- i cittadini non appartenenti all'Unione europea (cd. extracomunitari), che possono, invece, essere soggetti a restrizioni relativamente al loro diritto d'ingresso, di soggiorno e di permanenza nel nostro territorio.
11. Il Ripudio Della Guerra
Altro dettato normativo che rientra tra i principi fondamentali è l’art. 11 Cost., il quale costituzionalizza il principio secondo cui l'Italia ripudia la guerra in tutte le sue forme. Con tale espressione si riferisce principalmente alla guerra offensiva, ammettendosi dunque implicitamente la guerra difensiva, in caso di attacco militare da parte di una Forza straniera.
Gli articoli 78 e 87 Cost. precisano inoltre che spetta alle Camere il potere di deliberare lo stato di guerra e che tale dichiarazione spetta al Presidente della Repubblica.
L'articolo in esame dispone, inoltre, che l'Italia accetta limitazioni di sovranità all'interno del proprio territorio solo se necessarie al perseguimento della pace e della giustizia tra le Nazioni, tramite accordi con le stesse.
Tali limitazioni non riguardano solamente l'attività normativa dello Stato, ma anche quella giurisdizionale ed amministrativa, di tal ché i cittadini possono venir sottoposti, oltre che all'autorità nazionale, anche a quella straniere, ove vi siano specifici trattati in merito.
12. La Bandiera Tricolore
La collocazione della disposizione sulla bandiera nazionale all'interno dei principi fondamentali (art. 12 Cost.) va vista come particolarmente significativa, in quanto si è inteso dotare l'emblema della riserva costituzionale, sottraendola pertanto alla revisione di legge ordinaria.
Nel periodo fascista la bandiera costituiva il simbolo della sovranità dello Stato quale unico depositario dei valori nazionali, tant'è che era vietato esporre bandiere di altri stati senza apposita autorizzazione (l. 24 giugno 1929, n. 1085). Con la nascita della Repubblica essa diventa simbolo di uno Stato che si inserisce in un ordinamento internazionale del quale abbraccia e promuove i valori.
Il tricolore si ispira alla bandiera francese e la stessa divisione in tre bande è espressione dei principi democratici di libertà, uguaglianza e solidarietà.
13. I Doveri Inderogabili
L’art. 2 Cost., accanto ai diritti inviolabili, richiede l’adempimento dei “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”: si tratta di quelli dal cui adempimento nessun soggetto può essere esentato in quanto, attraverso la solidarietà, si adempiono compiti propri dello Stato sociale, nel quale l’agire del singolo deve sempre essere orientato al bene comune.
Dal diritto al lavoro al dovere al lavoro
Il lavoro, oltre ad essere un diritto fondamentale ex art. 4 Cost. è, anche un dovere di solidarietà, cui ciascun cittadino è tenuto ad adempiere onde contribuire al progresso economico e sociale dello Stato e della collettività.
A tale disposto costituzionale va correlato l’art. 38, c. 1, Cost., che, fondato unicamente sulla solidarietà collettiva, dispone che “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”.
Il dovere di votare
Altro dovere costituzionale è il dovere di votare che è un dovere civico, in quanto esercizio diretto della sovranità popolare e connotato fondamentale dalla democraticità dell’ordinamento.
La capacità di votare, vale a dire di esprimere la propria volontà politica attraverso il voto, si definisce elettorato attivo.
Due sono i requisiti richiesti: la cittadinanza italiana e la maggiore età, ossia il 18° anno di età (per il Senato tale requisito è elevato a 25 anni).
Le caratteristiche del voto sono:
- suffragio universale, per cui l’ammissione al voto non può essere subordinata a condizioni di carattere economico o culturale, né possono sussistere discriminazioni di sesso;
- personalità, l’unico modo di votare è quello di recarsi personalmente alla sezioni elettorale e di segnare di proprio pugno la scheda;
- eguaglianza, per cui sono esclusi i voti plurimi riservati a determinate categorie di persone o i voti multipli, cioè quelli che consentono ad un elettore di votare in più circoscrizioni;
- libertà, ad ogni elettore deve essere garantita la facoltà di attribuire il proprio voto a chi ritenga più opportuno, senza coercizioni di alcun tipo;
- segretezza, stabilita a tutela della libertà del voto, per garantire l’elettore da possibili pressioni esterne;
- non obbligatorietà, in quanto l’art. 48 Cost. stabilisce che l’esercizio del diritto di voto costituisce solo un dovere civico.
L’elettorato passivo, invece, consiste nella capacità di ricoprire cariche elettive.
Per il principio di coincidenza tra elettorato attivo e passivo, di regola chiunque sia elettore è, a sua volta, anche eleggibile. Per l’appartenenza alla Camera dei deputati tuttavia, l’età non può essere inferiore a 25 anni, per il Senato a 40 anni.
Il dovere di istruire ed educare i figli
L’art. 30, c.1, Cost. stabilisce che “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”.
In tal caso, il dovere di istruire ed educare i figli rappresenta una funzione sociale, mentre, il medesimo diritto è un vero e proprio diritto soggettivo.
Il dovere di difesa della Patria
La Carta costituzionale all’art. 52 contempla il dovere di difesa della Patria, considerato come “sacro” dal 1° comma della norma in esame.
Si tratta di “un dovere collocato al di sopra di tutti gli altri”, quale specificazione del più generico dovere di fedeltà alla Repubblica e di obbedienza alla Costituzione e alle leggi”. L’obiettivo della disposizione de qua è quello di tutelare e proteggere l’interesse dello Stato-comunità alla propria integrità territoriale, alla propria indipendenza e alla sua sopravvivenza.
Dal dovere in parola l’articolo costituzionale fa discendere l’obbligatorietà del servizio militare (comma 2, art. 52 Cost.), con la previsione di una riserva di legge per l’individuazione dei limiti e dei modi di esplicitazione di tale dovere.
Tale dovere ha, però, un’estensione più ampia dell’obbligo di prestare servizio militare e può essere adempiuto anche attraverso adeguate attività di impegno sociale non armato.
14. L’ordinamento Della Repubblica
La Parte seconda della Costituzione (artt. 55-139 Cost.) è dedicata all’ordinamento della Repubblica, nell’ambito della quale sono ricompresi gli organi costituzionale e gli organi di rilievo costituzionale.
Rientrano nella prima categoria quegli che godono di una posizione di autonomia e prendono parte all’individuazione dei fini che lo Stato è chiamato a perseguire, per questo si configurano come “poteri dello Stato”.
Le loro strutture, organizzazione e funzioni sono direttamente disciplinate dalla Costituzione per cui una modifica di esse importa un procedimento di revisione costituzionale.
Nello specifico, sono organi costituzionali: il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Governo e la Corte costituzionale.
Le caratteristiche fondamentali degli organi costituzionali sono:
- la sovranità, ossia la titolarità di funzione sovrane;
- la rappresentatività, essendo rappresentativi della volontà del popolo;
- la necessarietà, nel senso che sono indispensabili per il corretto funzionamento dell’ordinamento;
- l’indipendenza, in quanto non possono subire, nell’espletamento dei loro compiti, influenze e condizionamenti da parte di altri organi, siano essi costituzionali o meno;
- l’indefettibilità, che implica l’impossibilità di essere sostituiti da altri organi, se non per circostanze del tutto eccezionali, al fine di non alterare l’equilibrio istituzionale voluto dalla Costituzione.
Gli organi di rilievo costituzionale, invece, non sono essenziali alla struttura costituzionale dello Stato, pertanto sono solo individuati dalla Costituzione, la quale rinvia al legislatore ordinario la disciplina della loro attività.
Sono organi di rilevanza costituzionali: il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL di cui è auspicata da anni l’abolizione), la Corte dei conti, il Consiglio di Stato, il Consiglio Superiore della Magistratura e il Consiglio supremo di difesa.
In tale seconda Parte rientra, infine, anche l’organizzazione territoriale della Repubblica di cui fanno parte Regioni ed enti locali, nonchè il procedimento per la modifica della Costituzione e l’approvazione delle leggi costituzionali.
Il dovere tributario
Altro dovere sancito dalla Costituzione è quello di concorrere alle spese pubbliche e, quindi, di adempiere alle prestazioni tributarie.
L’art. 53 Cost. dispone, infatti, l’obbligo tributario, un obbligo che incombe su tutti, cittadini e non cittadini, stranieri o apolidi residenti nello Stato. Esso è, inoltre, commisurato alla capacità contributiva del soggetto passivo del tributo, e cioè all’idoneità di quest’ultimo all’obbligazione tributaria desumibile dalla concreta esistenza del presupposto economico relativo, cioè dal livello di reddito attribuibile complessivamente ad un soggetto.
Il 2° comma dello stesso art. 53 Cost. dispone che il sistema tributario sia informato a criteri di progressività, nel senso che l’imposizione deve essere più che proporzionale rispetto al reddito dichiarato e accertato, di modo che a diversi livelli di reddito corrispondano aliquote di imposta progressivamente crescenti.
Non vi è dubbio che il precetto costituzionale ha un fine politico- sociale diretto non solo a consentire allo Stato di sostenere le spese pubbliche, ma anche di realizzare una perequazione sociale, in attuazione dell’eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, c.2, Cost.
Il dovere di fedeltà alla Repubblica
L’ultimo dovere costituzionalmente sancito dal 1° comma dell’art. 54 Cost., che incombe su tutti i cittadini, è quello “di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi”.
La fedeltà della Repubblica si riferisce ai principi di una struttura dell’ordinamento democratico da quest’ultima fondato, che sono assolutamente intangibili e immodificabili, nemmeno con il procedimento di revisione costituzionale.
Quello che richiede il disposto costituzionale dal cittadino è che quest’ultimo osservi le regole della democrazia anche nel dissenso, ovvero non compia atti materiali violenti che possano compromettere il regolare svolgimento della vita democratica.
Il successivo comma della norma in commento impone, invece, ai cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche, l’ulteriore dovere di adempiere tali funzioni con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
Si tratta, quindi, di un dovere aggiuntivo a quello del comma 1 dell’art. 54 Cost. e che si collega all’art. 97 Cost., nel senso che esso è strumentale al perseguimento del buon andamento e dell’imparzialità della P.A.
15. La Revisione Costituzionale
Nella nostra Costituzione è l’art. 138 che disciplina la revisione della Costituzione e il procedimento di formazione di altre leggi costituzionali.
Per leggi di revisione si intendono quelle leggi che incidono sul testo costituzionale, modificando, sostituendo o abrogando le disposizioni in esso contenute.
Per altre leggi costituzionali si intendono, invece, le leggi che:
- sono espressamente definite tali dalla Costituzione, come ad esempio negli articoli 132 e 137;
- si limitano solamente a derogare una norma costituzionale, senza modificarla (ad es. L. n. 1/1993);
- le leggi che il Parlamento vuole approvare mediante il procedimento aggravato di cui alla presente norma.
Tanto le leggi di revisione che le leggi costituzionali richiedono per la loro approvazione lo stesso procedimento.
Il procedimento
Il procedimento di revisione si compone delle stesse fasi in cui si articola il normale procedimento legislativo, e cioè la fase dell’iniziativa, quella deliberativa e quella integrativa dell’efficacia. Nel procedimento de quo la fase deliberativa viene sdoppiata e quella integrativa dell’efficacia viene modificata in relazione a tale sdoppiamento.
Va, inoltre, sottolineato che la nostra Costituzione affida alle Camere l’approvazione delle leggi di revisione e delle leggi costituzionali, dettando solo procedimenti aggravati o superaggravati per alcuni tipi di leggi costituzionali.
Ritornando al procedimento:
- fase dell’iniziativa, l’art. 71 Cost. attribuisce il potere di iniziativa legislativa sia al governo, che ai singoli membri delle Camere, oltre che al popolo e agli “organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale”, quali il CNEL, relativamente alle materie riguardanti l’economia e il lavoro, e i Consigli regionali, limitatamente a materie di diretto interesse regionale.
- Fase deliberativa: si presenta particolarmente complessa e laboriosa, prevedendo due possibili procedure aggravate.
La prima procedura consiste:
- nell’adozione delle leggi costituzionali da parte di ciascuna camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi. In altre parole, si richiede l’impiego del criterio dell’alternatività, consistente nella deliberazione prima dell’una e poi dell’altra Camera, con la ripetizione di tali deliberazioni nella seconda votazione;
- e nella loro approvazione nella seconda votazione a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera.
La seconda procedura è analoga alla prima relativamente alla duplice approvazione entro l’intervallo di tre mesi da parte di ciascuna camera, solo che se nella seconda deliberazione si raggiunge la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna camera non si può dare luogo al referendum popolare.
- Eventuale procedimento referendario:
tra la fase deliberativa e quella integrativa dell’efficacia può
innestarsi quella diretta a permettere l’eventuale celebrazione del
referendum approvativo. In questa fase, che si può aprire solo se la
seconda deliberazione ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi, è
preceduta dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
proposta di revisione o di legge costituzionale, con il titolo: “Testo
di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza
assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera”,
titolo completato dalla data della sua approvazione finale da parte
delle stesse Camere e preceduto dall’avvertimento che, entro tre mesi,
un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque
consigli regionali possono domandare che si provveda al referendum
popolare.
In questo caso la pubblicazione assolve ad una funzione di mera conoscibilità, quale, mezzo cioè diretto “a far conoscere il testo di un progetto, così da rendere possibile una decisione circa l’opportunità dell’iniziativa” referendaria.
La richiesta di referendum deve pervenire alla cancelleria della Corte di Cassazione entro tre mesi dalla pubblicazione della proposta, e l’Ufficio centrale per il referendum presso la stessa Corte verifica la sua legittimità, e cioè la sua conformità alle norme dell’art. 138 Cost., decidendo al riguardo con ordinanza.
Se l’ordinanza dichiara l’illegittimità della richiesta, la legge costituzionale viene promulgata dal Presidente della Repubblica; se, invece, ne dichiara la legittimità, il Presidente della Repubblica indice con proprio decreto il referendum, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che lo ha ammesso.
In quest’ultimo caso la data di celebrazione del referendum va fissata in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo all’emanazione del decreto di indizione.
La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto. Per tale tipo di referendum non è prescritto alcun quorum, né di partecipazione né funzionale.
Se il progetto riporta la maggioranza dei voti validi, esso s’intende approvato e il Presidente della Repubblica procede alla sua promulgazione. Se, viceversa, il risultato referendario sia sfavorevole all’approvazione della legge, il Ministro della Giustizia provvede alla pubblicazione del risultato medesimo nella Gazzetta ufficiale.
Ovviamente se trascorrono i tre mesi senza che sia stata presentata alcuna richiesta di referendum, il progetto già approvato nella seconda deliberazione a maggioranza assoluta si consolida come legge a tutti gli effetti e da tale termine decorre il periodo utile per la promulgazione e la pubblicazione successiva.
- Fase integrativa dell’efficacia: in essa rientrano la promulgazione presidenziale della legge costituzionale e la pubblicazione della stessa. Quanto alla pubblicazione si applicano per essa le regole previste per le leggi ordinarie.
I limiti espliciti
Il solo limite esplicito alla revisione costituzionale è quello contenuto nell’art. 139 Cost., secondo cui “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”.
Tale norma va letta in connessione con l’art. 1 Cost.: la forma repubblicana, realizzando “una democrazia fondata sul lavoro”, è coessenziale al regime.
Inoltre, dall’art. 2 Cost., che qualifica come inviolabili i diritti dell’uomo, si trae l’ulteriore limite esplicito alla revisione costituzionale, inteso come inderogabilità di tali diritti di libertà, ma con la precisazione che la revisione potrà apportare delle modifiche alla regolamentazione costituzionale non solo per svolgerla, perfezionarla, ampliarla, ma anche allo scopo di adattarla a sopravvenute esigenze, le quali potrebbero esigere una disciplina difforme, me sempre in termini circoscritti e tali da non intaccare l’essenza dei diritti stessi.
I limiti impliciti
La locuzione “forma repubblicana” presente nell’art. 139 Cost. viene altresì interpretata in senso riassuntivo di ciò che evoca l’idea di repubblica: eguaglianza formale e sostanziale, diritto di voto, libertà di manifestazione del pensiero, di riunione, ecc.
In altri termini, da tale disposizione vengono tratti alcuni principi ritenuti supremi o istituzionali e di struttura della nostra Repubblica, quali limiti impliciti della revisione e quindi immodificabili, principi comprendenti, oltre quelli già citati, anche i principi personalista e comunitario, quello lavoristico, la rappresentatività degli organi fondamentali, nonché i principi pluralistico, solidarista, di unità e individualità della Repubblica, di tutela delle minoranze.
 Pluris, CEDAM, UTET Giuridica, Leggi d'Italia, IPSOA ti presentano One LEGALE:
la nuova soluzione digitale per i professionisti del diritto con un
motore di ricerca semplice ed intelligente, la giurisprudenza commentata
con gli orientamenti (giurisprudenziali), la dottrina delle riviste ed i
codici commentati costantemente aggiornati.
Pluris, CEDAM, UTET Giuridica, Leggi d'Italia, IPSOA ti presentano One LEGALE:
la nuova soluzione digitale per i professionisti del diritto con un
motore di ricerca semplice ed intelligente, la giurisprudenza commentata
con gli orientamenti (giurisprudenziali), la dottrina delle riviste ed i
codici commentati costantemente aggiornati.